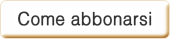EDITORIALE L'ARCO DI GIANO n° 74 - 2012
| INDICE | EDITORIALE | AUTORI |
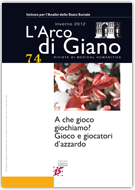
A che gioco giochiamo? Gioco e giocatori d'azzardo
N° 74 - inverno 2012 |
|
Curare questo numero dell’Arco di Giano dedicato al Gioco d’Azzardo, l’ultimo del 2012, è stata davvero una bella sfida data l’attualità del problema che potrebbe esploderci in mano, senza che molti si siano ancora accorti della sua gravità. Proprio per questo sono grata ai contributi preziosi di tutti gli autori che hanno collaborato, con intelligente generosità, senza sottrarsi alla complessità di un problema, che sta diventando una metafora della post-modernità in cui si snoda la nostra attuale esistenza. Nessuno si è limitato a ripetere slogan facili, già consolidati nella prassi pubblicitaria, ogni autore è andato volutamente controcorrente, con il coraggio di chi intende fare una denuncia forte, al di là della quale non siano più possibili comodi alibi da parte di nessuno. Circa un anno fa con un piccolo gruppo di colleghi parlamentari, tutti afferenti a vario titolo all’area di centro, abbiamo deciso di dare vita ad una campagna forte di tutela delle fasce fragili, soprattutto giovani, cominciando con un Convegno che si è svolto alla camera dei Deputati e in cui sono stati relatori quasi tutti gli autori di questo volume. Dalla stima reciproca, dalla convinzione della gravità del problema, che si andava configurando come una vera e propria piaga sociale, è nato il progetto che prende forma in questo volume. C’è la consapevolezza che solo insieme, scegliendo una chiave interdisciplinare e interprofessionale, è possibile rallentare il decorso di questa patologia e dare vita alla speranza di una possibile inversione di marcia di un processo, che non è legato ad un determinismo irrazionale. Risponde piuttosto a precisi interessi di parte che abbiamo voluto denunciare con coraggio, pronti ad assumerci la responsabilità del caso. È un tentativo concreto di reagire davanti allo sconforto, che nasce guardando tante famiglie che vanno in pezzi, tanti giovani che gettano all’ammasso le loro migliori energie intellettuali e morali, ma anche tanti pensionati che si giocano le loro pensioni al gratta e vinci, tante casalinghe amareggiate e deluse che passano i loro pomeriggi davanti ad una slot machine, tanti adulti, giovani e meno giovani, che bruciano molto del loro tempo davanti alle videolotterie o in lunghe lunghissime partite di pocker on line. Ognuno degli autori ha affrontato il tema, senza mai banalizzarlo, documentandosi con grande consapevolezza, convinti della gravità del problema e della responsabilità precisa che coinvolge tutti a livello personale, istituzionale e sociale. Il filo conduttore del testo inizia con la testimonianza del Ministro Riccardi, il quale afferma: "Vorrei dire che ho sentito, nella mia veste di Ministro con delega alle Politiche giovanili ed alla Famiglia, che la questione della ludopatia andava affrontata con la massima decisione. La ludopatia sembra essere un poco l’opposto del gioco. Il gioco ha, per suo statuto, una valenza sociale che si coniuga con aspetti quali la gratuità, la libertà, lo svago. La ludopatia, invece, oltre a caratterizzarsi per l’elemento di compulsività, quel richiamo irrefrenabile a ripetere il gesto, non ha alcuna valenza sociale ed è realmente, un’oscura dipendenza….". Non di gioco quindi si tratta ma di compulsione a ripetere, in cui la libertà del giocatore appare compromessa dal senso di coercizione interna che obbliga a giocare, nonostante tutto! Il Ministro ci tiene a mettere in evidenza come questo fenomeno pur vedendo l’Italia in pole position, non è un fenomeno solo italiano e sono enormi gli interessi economici che lo presidiano, per cui aggiunge: “Una recente risoluzione del Parlamento Europeo auspica una maggior cooperazione, al fine di contrastare il mercato nero e proteggere i bambini ed i consumatori considerati più a rischio… Il gioco d’azzardo, attraverso le nuove tecnologie, può comportare un maggior rischio di dipendenza ed occorrono norme precise per la tutela dei consumatori”. Emanuela Baio interviene subito dopo ricollegandosi ai rischi legati al fenomeno della crescita dei punti di gioco, veri e propri punti di infezione in un sistema malato e in gran parte svuotato dalla capacità di reagire adeguatamente. In questa linea sostiene: “Ai giocatori più attivi non sarà sfuggita l’istituzione del Bingo a distanza, l’apertura di mille sale da gioco per lo svolgimento del poker dal vivo, l’aumento del numero delle VideoLettery, l’apertura di 7 mila punti vendita per le scommesse su base ippica e sportiva, l’ampliamento dell’offerta dei giochi numerici e l’introduzione di un nuovo gioco su base europea”. Le ragioni per lei sono facilmente identificabili nel fatto che le “note dinamiche internazionali inducono il Governo a varare a distanza di un mese, un ulteriore provvedimento, conosciuto come la manovra di Ferragosto del 2011, e, ancora una volta, l’azzardo è la fonte più attraente per incrementare le entrate erariali. Il Governo, in questo caso, non ha usato mezzi termini ed ha delegato i Monopoli di Stato ad adottare tutte le disposizioni utili al fine di assicurare maggiori entrate: via libera a nuovi giochi, a nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, nuove modalità di gioco del Lotto, nuovi giochi numerici a totalizzazione nazionale”. Il suo giudizio è lapidario, secco e tagliente: “È il buio della ragione misto al delirio di onnipotenza; è l’insana febbre del gioco, figlia di ogni epoca, ma che oggi è fomentata dal continuo incremento dell’offerta, dalla diffusione di campagne pubblicitarie aggressive e maledettamente accattivanti, dalla moltiplicazione esponenziale dei locali da gioco”. Il suo intervento si conclude comunque con un tentativo di soluzione a cui si lega una debole, ma irrinunciabile speranza: “Vi è, tuttavia, un trittico che registra l’unanime condivisione dei soggetti a vario titolo interessati da tale fenomeno, compresi i gestori, ed è quello che individua nella lotta all’illegalità, nella diffusione di corrette campagne pubblicitarie e nell’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza dei disturbi connessi al gambling patologico. Le tre priorità non più rinviabili che lo Stato deve perseguire…”. Le fa eco Mariapia Garavaglia, che riprendendo con toni altrettanto drammatici la sua stessa denuncia, apre però la strada ad un nuovo e più forte fattore di prevenzione e di contrasto alla ludopatia: la formazione e la responsabilità che in tal senso la scuola deve assumersi davanti ai giovani. “Questa loro testimonianza è preziosa, perché la dipendenza dal gioco si attiva spesso per emulazione... Per questo motivo è essenziale, prima di affrontare una riflessione sulla cura, che ci dedichiamo alla prevenzione. Si tratta di “iniettare” nel tessuto sociale, a partire dalle giovani generazioni, la cultura di senso: della propria vita, dei beni strumentali, delle scelte etiche ed economiche. Non saranno però né le esortazioni, né le sanzioni a convincere i giovani perché non consumino la loro età senza senso. Hanno bisogno di esempi, non di prediche. Gli adulti devono utilizzare gli attrezzi funzionali alla buona azione educativa; innanzitutto la scuola. È l’istituzione cui è affidata la responsabilità di rimuovere le differenze di partenza,cominciando dai primi gradini di una scala che dovrebbe condurre alla meta, cioè al raggiungimento di una pienezza di cittadinanza che consenta di mettere a disposizione, per sé e per l’intera comunità, i talenti di cui si è titolari. La scuola può esprimere la sua finalità quanto più il Paese - lo Stato - se ne cura….”, ma con grande dispiacere occorre riconoscere che da qualche anno non è più così: “Dobbiamo constatare un indebolimento della istituzione principe dedicata al sapere, agli strumenti guida nella società del sapere. Tutte le riforme della scuola - dalla primaria all’università - hanno ristretto (da molti anni ormai) il flusso finanziario, con la giustificazione che la qualità non necessariamente dipende dalla quantità. Mi sto riferendo alla qualità della educazione alla cittadinanza...“ e conclude: “Gli adulti si propongano con idee chiare sul valore del lavoro, sulla selezione per merito, sull’avanzamento sociale attraverso l’impegno personale, aperti e generosi. Se gli educatori dimostrano quale è la giusta dimensione del denaro, perché non sia l’unico obiettivo della vita, non accadrà che i giovani affidino all’avidità la chiave del successo…”. Per Matteo Iori la prima battaglia però va combattuta sul fronte della pubblicità, che riesce a vanificare qualsiasi proposta educativa, proprio per il suo carattere invasivo, a volte accattivante, ma più spesso aggressivo. “I cittadini italiani sono quotidianamente raggiunti da innumerevoli pubblicità che tendono a indurli a credere che la vincita sia a portata di mano e che basti giocare per cambiare finalmente vita. A chi non piace “vincere facile”? …. Eppure nel gioco d’azzardo non vi è nulla di più errato. Adam Smith, economista del diciottesimo secolo, già allora scriveva due cose molto importanti: “Non è mai esistita, e mai esisterà al mondo, una lotteria perfettamente equa” e ancora “nessun uomo, per quanto sano, è immune dall’assurda fiducia nella propria fortuna”. Le due riflessioni di Adam Smith sono traducibili con questi due assiomi del gioco d’azzardo: da sempre chi realmente vince al gioco è esclusivamente il Banco, cioè chi gestisce l’azzardo, e ogni giocatore ritiene di poter in qualche modo pilotare la propria fortuna. Quasi tutte le persone quando comprano un gratta e vinci, o un biglietto della lotteria, o giocano dei numeri al lotto, fanno un pensiero matematicamente “illogico”: cercano di influenzare il destino indicando dei numeri specifici (i propri “numeri fortunati”), o scegliendo un biglietto determinato, e non uno a caso passatogli dal venditore. L’idea del dominare il caso e di poter influire sulle sequenze aleatorie è tipica di ognuno di noi, ma c’è chi su questa idea illogica costruisce una fortuna: sono le industrie dell’azzardo. Paolo Canova e Diego Rizzuto, due giovani e brillanti matematici hanno individuato nei giochi di simulazione, giocati rigorosamente senza denaro in palio, un potente fattore di educazione dissuasiva dal gioco. “Smascherare la seduzione del gioco d’azzardo con i suoi stessi argomenti”. Il loro obiettivo è quello di sostituire ad un trito e sostanzialmente inefficace paternalismo una condivisione chiara e trasparente dei saperi, attraverso una campagna di controinformazione, condotta attraverso incontri pubblici nelle scuole e nei teatri, che consenta di incontrare le persone, studenti compresi, per dar loro un’idea, se non esaustiva, almeno chiara e priva di ambiguità delle conseguenze in cui è possibile incappare quando si gioca senza rendersi conto di ciò che accade nelle stesse fasi del gioco. Nell’iniziativa e quindi nella relazione di Paolo Canova e Diego Rizzuto il “gioco è nudo” e tutti possono osservare ciò che realmente accade, al netto delle facili promesse degli esercenti del gioco d’azzardo. “L’unica alternativa che vediamo è una comunicazione comprensibile e partecipata che fa del linguaggio accattivante, dell’approccio interattivo e dell’attenzione per gli interessi del pubblico le sue armi più affilate. … L’esperire in prima persona il meccanismo della lotteria attraverso la simulazione pone l’oggetto della discussione in una prospettiva molto più tangibile del mero discorso parlato. … l’assenza del premio non modifica in maniera sostanziale lo scossone emotivo che provoca un’eventuale vincita, ossia la convinzione (ovviamente erronea) di essere stati più bravi degli altri…”. Una volta concluso il gioco, si passa a una approfondita discussione delle ragioni matematiche che si nascondono dietro ai fatti di cui si è appena stati testimoni. Vengono descritte nel dettaglio le probabilità corrispondenti ai vari risultati per mezzo di facili calcoli e di semplici grafici… Per Savino Pezzotta però non è sufficiente sconfiggere il problema sulla base di una elaborazione culturale di stampo matematico. Le dimostrazioni evidenti della fallacia delle promesse in gioco toccano due tasti più profondi e complessi, da un lato la patologia e dall’altra la mancanza di un riferimento etico chiaro. “Numerosi studi sugli effetti sociali del gioco d’azzardo evidenziano con dovizia di particolari che sono ormai una malattia la cui gravità è direttamente proporzionale all’accessibilità dell’offerta: i problemi aumentano man mano che crescono le possibilità di giocare. Da qui la convinzione che esista un problema morale anche per il governo che li promuove e che ci guadagna. Molte sono le prove contro il gioco, spesso legato alla debolezza della famiglia, alla violenza domestica, al fallimento delle proprie prospettive di vita o di carriera…. Molti studi hanno dimostrato che i più vulnerabili al gioco in tutte le sue forme, sono le persone più deboli, meno istruite e povere. A fronte di queste considerazioni occorrerebbe avviare un processo di riduzione e contrazione delle possibilità di gioco” . E invece paradossalmente assistiamo a fenomeni di segno totalmente diverso: “Studi scientifici hanno ormai identificato una serie di difficoltà delle persone, delle famiglie e delle comunità, che possono essere direttamente o indirettamente derivanti dalla pratica del gioco d’azzardo: disfunzioni familiari e violenza domestica; disturbi psichiatrici, tra cui depressione, disturbo antisociale della personalità, ansia e progressivo indebolimento della capacità di attenzione; crescita dell’ideazione e dei tentativi di suicidio; aggravamento dei problemi economici, compresi i fallimenti, la perdita del posto di lavoro e la povertà che ne può derivare; comportamenti illegali quali il furto, la prostituzione, il traffico di droga. Tener conto di queste patologie sociali è estremamente utile, anche se la prudenza ci invita a non farne derivare con certezza una relazione causale con il gioco”. Alle preoccupazioni di Pezzotta fanno eco anche le mie osservazioni. Paola Binetti infatti sottolinea la frattura etica che si rivela nel gioco d’azzardo, proprio per le dinamiche che presidiano il fenomeno dall’interno. “Di fatto la pubblicità, parlando alla parte emotiva e meno razionale dell’uomo, mette in moto una sorta di pensiero magico che insinua in modo subdolo e aggressivo messaggi ingannevoli sulle reali possibilità di vincere, per cui in assenza di un pensiero critico diventa facile credere, o per lo meno sperare di vincere. Nella sperimentazione quotidiana della realtà un soggetto utilizza abitualmente due tipi di pensiero diversi: il pensiero “razionale” e il pensiero “magico”. Il primo si basa sulla logica e sul ragionamento, sulla capacità di fare ipotesi e di verificarle attraverso il ragionamento matematico, il calcolo delle probabilità e operazioni spazio-temporali; è il pensiero che caratterizza il ragionamento scientifico. Si sviluppa durante l’adolescenza e accompagna tutta la vita dell’uomo. Il pensiero magico è più infantile ed è caratterizzato dalla tendenza a mettere in relazione tra di loro fenomeni che in realtà sono totalmente indipendenti. La presenza del pensiero magico è predominante nella vita infantile”. Ma i gestori del gioco d’azzardo sfruttano la sua persistenza anche in età adulta per incentivare, con messaggi e campagne pubblicitarie un consumo di gioco da cui trarre profitti e business. Fortunatamente i giocatori non sono tutti uguali. Alcuni giocano solo per divertirsi, con una certa curiosità ma anche con un adeguato distacco; altri nel gioco cercano una compensazione rispetto a frustrazioni, problemi, preoccupazioni di vario tipo. Altri utilizzano il gioco per superare uno stato di tristezza, di depressione o di ansia; altri cercano nel gioco l’eccitazione e l’adrenalina necessarie per sentirsi “vincenti”; altri ancora vivono una situazione di tale fragilità psicologica o sociale che quasi non sono consapevoli di quanto il gioco sia per loro pericoloso. Donato Mosella e Cristina De Luca firmano i due interventi successivi. Donato Mosella tratta del tema gioco dimenticato come del primo antidoto al gioco d’azzardo giovanile, dicendo: “Potrebbe essere proprio la restituzione ai giovani del significato più autentico del gioco, la riconquista della dimensione ludica alternativa al rischio, allo sballo, alla corsa all’eccesso. Spetta a noi adulti, però, recitare il mea culpa se la presenza del gioco nella formazione del fanciullo e del giovane tende a indebolirsi e sparire, e se il significato del gioco viene frainteso confondendolo con il rischio e l’eccesso. Come è noto, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia riconosce al fanciullo (art. 31) il diritto al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età. In Italia, però, stiamo togliendo ai bambini il gusto di avventurarsi nel mondo per poterlo scoprire a poco a poco seguendo istinto e fantasia, attraverso il movimento e il gioco spontanei all’aria aperta. L’accusa ha l’autorevole avallo della Società Italiana di Pediatria (SIP). L’80% dei bambini non gioca più all’aria aperta, tanto meno gli è permesso “inventare” il tempo e il luogo del gioco. I genitori impongono che il gioco avvenga in spazi chiusi e vigilati, come le ludoteche, o in recinti attrezzati predisposti nei giardinetti e nei parchi. C’è da riflettere, considerando che spesso negli stessi parchi vi sono altri spazi attrezzati, anche più grandi, previsti come aree di gioco, di movimento e di addestramento per l’amico dell’uomo, il cane. È mai possibile che a un bambino possa essere sufficiente la stessa possibilità di sperimentare il gioco in libertà che si concede al Fido di famiglia?”. E’ evidente che l’autore di questo capitolo non intende togliere nulla ai cani e al riconoscimento dei loro diritti, che sta guadagnando spazi continua di nuove e incisiva visibilità, ma vuole porre il bambino al centro della riflessione di tutta la società, non solo di quella politica. Continua infatti Mosella: “Colpa anche dell’urbanistica degli ultimi decenni. I nuovi quartieri cittadini non prevedono più spazi liberi e sicuri per il gioco infantile. Quelli che c’erano nei vecchi quartieri sono stati destinati ad altri usi o il traffico li rende insicuri. Giocare nelle aree verdi, senza barriere? Non si può: il cartello di “Vietato calpestare l’erba” o di esplicito divieto di gioco affiora sui prati delle ville cittadine, oggi concepite come “musei del verde” da guardare, non toccare e non calpestare. La responsabilità maggiore, però, riguarda i genitori che non consentono ai figli di muoversi se non a loro stretto contatto. E pensare che i pediatri chiedono che i genitori lascino ai figli la disponibilità del tempo libero, li facciano andare a scuola a piedi, in gruppo con gli amici, affidino loro qualche piccola commissione da sbrigare da soli.” Su questa stessa linea si muove Cristina De Luca, che richiama l’attenzione sul Rapporto Sociale 2011, in cui si presenta l’elaborazione di un Piano strategico basato su tre principali aree di intervento: tutela dei minori con iniziative per garantire il divieto assoluto di gioco ai minorenni; comunicazione responsabile orientata alla promozione di un sano modello di gioco; prevenzione delle forme di eccesso e assistenza ai giocatori problematici. Per cui la De Luca continua: “Si può così comprendere come nella lotta al gioco d’azzardo patologico, a partire dalla cura e sostegno, fino alla prevenzione, alla sensibilizzazione, passando per lo studio e il monitoraggio, l’Associazionismo può avere un ruolo particolarmente significativo. È altrettanto evidente che l’azione non può essere pienamente efficace senza un rapporto costante tra i diversi attori in gioco che sono molto spesso portatori di interessi contrastanti tra loro. Da una parte le Concessionarie dello Stato e lo Stato stesso che può, nonché deve, essere senza indugi garante di un uso responsabile del gioco; dall’altro tutto il mondo della cura e del sostegno, dalle Associazioni, alle Asl . la necessità che emerge con forza è quella di un’azione di rete che rende efficaci gli interventi e di avviare percorsi condivisi per combattere la ludopatia e i drammatici risvolti connessi. La rete permette di valutare con attenzione le sperimentazioni , di definire delle priorità, di condividere esperienze e modalità d’azione. In tal senso alcuni segnali degli ultimi tempi appaiano confortanti perché evidenziano una volontà comune di affrontare un tema dai contorni chiari ma dalle ripercussioni molto ampie. La partita in gioco - se così si può dire - come ci dicono i numeri, è alta”, ma proprio per questo conclude l’autrice: “Si deve evitare di entrare in una logica di scarico di responsabilità …“ In questa prima parte degli interventi gli autori hanno avuto come punto di riferimento costante la persona, il suo bisogno fisiologico di giocare e la potenziale deriva di questo bisogno in una patologia che necessita di cure. Una patologia che quando si instaura appare grave, contagiosa e ben difficilmente curabile. Lo Stato finora è rimasto in gran parte sullo sfondo, salvo per la ben nota consapevolezza che la gestione dei giochi sia di stretta competenza dell’AAMS: Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che li gestisce dandoli in “appalto” ad alcuni esercenti, e riservandosi una parte del loro ricavato per fronteggiare le necessità del sistema-Paese. Claudio Gustavino e Giorgio Schiappacasse assumono infatti un approccio colonico-sociale per sostenere che: “Il panorama dei problemi correlati all’azzardo è molto più ampio di quanto ci piace immaginare e considerare. Questo panorama è così complesso che possiamo ritenere che tutta la nostra comunità sia toccata in modo diretto o indiretto da questo problema e dalle sue conseguenze. Tocca a Luca Mencacci osservare il gioco d’azzardo nell’immagine che ne danno i mass media. Nella sua analisi attenta delle molteplici modalità con cui il gioco d’azzardo è raccontato dai Mass Media affiora tutta la contraddizione del legislatore, che resta l’elemneto di maggiore sorpresa, e spesso di uno stupore attonito, quando ci si imbarca in una riflessione sul gioco d’azzardo, sui suoi silenzi e sulle promesse vane e pericolose, senza alcuna azione di contrasto seria. “Non si tratta solo di mettere in discussione l’autorevolezza di un legislatore che da un lato incoraggia i cittadini a partecipare a lotterie, a giochi d’azzardo e scommesse, solo per aumentare le rendite fiscali, e dall’altro ne liberalizzi l’esercizio anche perché incapace di contrastarne in altro modo la diffusione illegale. Autorevolezza peraltro già fortemente incrinata anche solo dall’evidenza empirica che la strategia adottata ha poi provocato un incredibile allargamento della platea dei giocatori, tanto da suggerire a molti commentatori l’epiteto ben poco edificante di “stato biscazziere”. Bisogna invece denunciare l’adozione di un linguaggio e di uno stile di comunicazione che rendono quell’esortazione alla responsabilità talmente debole quasi da giustificarne la misera collocazione nelle pubblicità cartacee ai confini dell’orizzonte visivo sul quale si concentra l’occhio del lettore, ovvero al termine di uno spot televisivo quando già un irresistibile jingle ha completamente indirizzato l’attenzione dell’ascoltatore verso le piacevoli conseguenze di facili vittorie. Oggi poi che la sobrietà non sembra essere lo stile di vita maggiormente in voga la normativa sul “gioco sicuro e responsabile” rischia di trasformarsi in un alibi rischioso quanto deprimente, che distoglie il dibattito dalla reale inefficacia sin qui dimostrata nel controbattere la pervasiva quanto seducente presenza dell’azzardo sui media. Solo la presunzione di un sentimento di vergogna per aver contribuito a fomentare un fenomeno che non si è più in grado di controllare, del resto, potrebbe giustificare un comportamento che pone il legislatore alla stregua di quei “piazzisti di enciclopedie” che, dopo aver pubblicizzato le meraviglie della propria opera, celano dietro l’offerta scontata del primo numero i costi complessivi dell’intero impegno. Quasi ad avallare la misera conclusione che, laddove la logica prevalente sia quella del libero mercato, il cittadino non possa ambire a tutele superiori a quelle pretese da un qualsiasi consumatore. Ma l’eccesso di timidezza che si rimprovera al legislatore per evitargli la ben più grave accusa di indifferente cinismo, rischia di sottovalutare il ruolo dei messaggi pubblicitari nella nostra società e la reale portata di quelli relativi al gioco d’azzardo in particolare. Se anche ci limitassimo a considerare la pubblicità solo come una privilegiata chiave di lettura dei processi culturali in atto, sarebbe difficile evitare di rimproverargli un imprudente e sconsiderato atteggiamento di eutanasia sociale, laddove le sue scelte basate sulla rimozione di un giudizio etico hanno condotto inesorabilmente all’esautorazione della politica”. Gli ultimi due interventi sono a carico di Valentina Boccia, che ci offre un’analisi critica molto efficace del conto economicosociale del gambling e di Maurizio Fiasco, sociologo, da moltissimi anni impegnato nel Comitato anti-usura che opera soprattutto nell’ambito del gioco d’azzardo. Per Valentina Boccia:” I benefici per l’economia pubblica risiedono, quindi, in quei “pochi, maledetti e subito” 8,6 miliardi di euro, che alimentano un sistema fiscale in difficoltà, che addirittura preferisce avere un’entrata certa piuttosto che provare ad incrementare la propria quota. Citando l’ultima relazione della Corte dei Conti, infatti, “le entrate erariali difficilmente, ormai, si potranno attestare su livelli di molto superiori a quelli già raggiunti, pur dovendosi tenere conto dell’ulteriore positiva evoluzione che la raccolta lorda potrebbe subire anche per effetto dell’ulteriore sviluppo dei giochi on line”….. lo Stato non può e non deve ignorare il circuito del gioco illegale, che alimenta le mafie e ammonta a circa 10 miliardi, secondo le stime di Guardia di Finanza e Monopoli di Stato, i cui danni sociali si sommano a quelli del gioco patologico, ancorché legale.” Maurizio Fiasco introduce il suo intervento dicendo: “Devo alle Fondazioni Antiusura, l’originale esperienza di aiuto alle famiglie gravemente indebitate, sorta su impulso della Chiesa e lo studio continuativo del fenomeno del gioco d’azzardo,condotto sin dal 1999. Sono trascorsi tredici anni e la Consulta, che raggruppa ben 28 fondazioni, non ha mai cessato di essere un osservatorio costante e perfezionato: poiché assiste sempre più numerose famiglie che un loro congiunto ha gettate in miseria per irrefrenabili abitudini di gioco d’azzardo”.In queste poche parole ci sono quattro delle osservazioni fondamentali, indispensabili per capire come venir fuori da questa vera e propria epidemia sociale. Il contrasto all’usura, uno dei sintomi più gravi di un sistema sociale malato, in cui si annida il cancro della illegalità e della stessa criminalità. Il ruolo della iniziativa privata, che per impulso della Chiesa riesce a strutturarsi sotto forma di vere e proprie fondazioni, capaci di collaborare tra di loro per sostenere le famiglie dei soggetti affetti da GAP. La necessità di disporre di un servizio di osservazione che aiuti a comprendere come il fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo vada evolvendo, cogliendo le trasformazioni piccole e grandi che lo accompagnano. E infine, la gravità dello status delle famiglie di questi giocatori, che in alcuni casi non solo perdono il lavoro, ma anche la casa e si riducono in uno stato di miseria morale e materiale ben difficile da risolvere. L’ultima relazione è di Raffaele Lauro, che lancia un vero e proprio atto di accusa verso chi è responsabile della attuale devastazione economica e sociale. “Le cause di fondo di questa intollerabile situazione sono imputabili alla miopia della classe politica; alle responsabilità dirette dei governi di centro-sinistra, di centro-destra e dell’attuale governo tecnico; all’assenza sul problema del parlamento repubblicano (ci sono stati più dibattiti sul gioco nel Senato del Regno!) e al silenzio omertoso della grande stampa, dovuto al ricatto dei contratti pubblicitari dei concessionari (mai inviati all’antimafia, nonostante le ripetute richieste). Il mercato del gioco d’azzardo, in particolare dal 2001 al 2012, si è espanso in maniera esponenziale, a fronte di una totale inadeguatezza normativa. L’espansione del gioco d’azzardo secondo Lauro è da attribuirsi a tre false argomentazioni: il mercato legale, che in questo modo recupererebbe spazio e fatturato (in nero) rispetto a quello clandestino ed illegale. Ma questo grande alibi è crollato di fronte alle indagini della commissione antimafia, in quanto è stato accertato che esiste un “continuum” tra mercato legale e mercato illegale, al punto che la criminalità organizzata utilizza il marketing legale per il “suo” mercato clandestino (non esiste una discontinuità, perché la criminalità controlla sul territorio, attraverso dei prestanome, tutto il sistema del gioco, quello cosiddetto legale e quello illegale); che è in corso una caduta rapida delle entrate erariali perché che le somme ricavate dalle vincite vengono quasi tutte “reinvestite” nel gioco ed alimentano, di conseguenza, il gioco patologico e, infine, che i costi sociali non sono stati ancora calcolati, ma peseranno, in futuro, sul bilancio dello Stato e sulla comunità nazionale. Concludo questo lungo editoriale, che ho immaginato come un filo di Arianna, per orientarsi all’interno del testo. Ho voluto infatti evidenziare il filo conduttore che attraversa tutti gli interventi degli Esperti per rivelarne l’intrinseca organicità, sollecitando i lettori a considerare sempre il fenomeno dell’azzardo con uno sguardo d’insieme, con le sue luci -davvero poche - e con le sue ombre drammaticamente devastanti, quando i giocatori varcano la soglia del gioco patologico. Ognuno ha dato un suo specifico contributo che riflette quanto sia preoccupante un fenomeno che interpella le nostre specifiche professionalità per porvi argine con energia e determinazione, senza chiuderci in uno sterile lamento e senza attendere soluzioni magiche, né dal Governo né da nessun altro. La responsabilità è di tutti noi e il contagio va bloccato all’origine, aiutando le persone a scoprire il gusto di un progetto di vita in cui si possa giocare, senza mai rinunciare alla nostra libertà personale. |
|
di Paola Binetti |